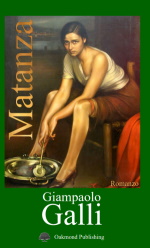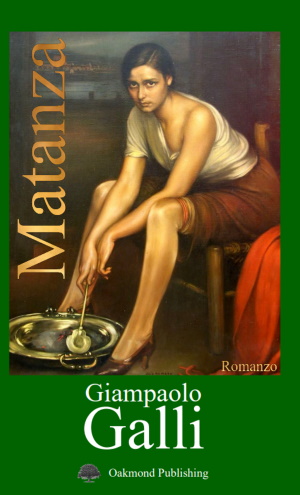
Matanza di Giampaolo Galli –
Violenza, orrore e insensata ferocia contro il popolo dei vinti
- Titolo: Matanza
- Autore: Giampaolo Galli
- Lingua: Italiano
- Formati: kindle, copertina flessibile
- Editore: Oakmond Publishing (2020)
- Generi: Romanzo, Thriller, Romanzo storico, Narrativa
Matanza è la storia di uno spaventoso massacro realmente avvenuto nella città di Torreòn, durante la rivoluzione messicana. Protagonista del romanzo è Juana, una ragazza indigena che viene avviata alla prostituzione da un abietto sfruttatore. Travolta dalla violenza di una guerra senza fine, Juana cerca di riscattare se stessa e dà voce agli ultimi della sua terra, quei popoli nativi, che pur costituendo l’anima più antica della nazione messicana, lottano ancora oggi per avere diritto a un futuro.
La mattanza di Torreòn, rimasta impunita, è una delle pagine più buie e sanguinarie dell’intera storia dell’America Latina.
Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile
Comincia a leggere qui gratuitamente l’incipit del libro
Matanza:
1
Estado de Nuevo Leòn, Messico, 1910
Il minuscolo villaggio senza nome era abbarbicato sulle pendici scoscese del Cerro San Rafaèl, un colosso di scura andesite incappucciato dall’ultima neve primaverile. Tutt’intorno, rilievi più modesti incisi da profonde barrancas drenavano le acque cristalline della Sierra Madre Orientale verso l’assolata piana di Monterrey.
Lungo lo stretto viottolo che portava al villaggio, la sagoma scura di un uomo alla guida di un malandato calesse si stagliava nella luce rosa del tramonto. Mentre procedeva fra gli scossoni provocati dal terreno accidentato, un cane dal pelo ispido gli tagliò la strada e abbaiò quasi controvoglia al cavallo, che nemmeno si scompose.
La piccola estancia era formata da una decina di bassi fabbricati di paglia e fango intonacati di bianco. Da un paio di essi usciva un sottile filo di fumo, che giunto a una certa altezza si espandeva nell’aria fino a scomparire, inghiottito dal cielo blu. Il calesse si arrestò davanti alla prima casa e il cane, che continuava a gironzolare incuriosito attorno al cavallo, sobbalzò all’indietro ringhiando non appena l’uomo gli si parò dinanzi, inaspettato.
Il carrettiere si guardò attorno per alcuni istanti; a parte il cane e alcune galline, il posto pareva deserto.
Bussò tre volte alla porta, fece un passo indietro e aspettò. Sulla soglia apparve una donna dai capelli lunghi e scarmigliati che lo squadrò con aria stanca; quindi abbassò lo sguardo e lo invitò a entrare.
L’uomo dovette chinare il capo per valicare l’ingresso. Una volta dentro, si tolse il cappello e attese che la vista si abituasse a quel buio improvviso; poi fece scorrere lo sguardo tutto intorno, alla ricerca di quello per cui era andato fin lì. Sulla panca di legno vicino al tavolo scorzato, sedeva una giovane ragazza di diciassette anni dall’aria tesa e impaurita. Aveva lunghi capelli neri, lisci e setosi, che incorniciavano un volto dai lineamenti aggraziati. Quando alzò lo sguardo verso di lui, dischiuse le labbra piene e ben disegnate in un’espressione di sbigottimento. Tutto in lei emanava una forte sensualità, e l’uomo avvertì un brivido di piacere salirgli dall’inguine. Accanto aveva un sacco di iuta con le sue povere cose già impacchettate, e cinque fratellini che sgranavano gli occhi scuri su quell’individuo dalla faccia così austera.
«È lei?»
«Sì», rispose la donna.
L’uomo squadrò la ragazza, poi prese dalla tasca della giacca un piccolo rotolo di banconote sgualcite legate con lo spago e lo diede alla madre. Con un leggero movimento del capo fece cenno alla ragazza di uscire e si avviò verso il calesse. La donna, con gli occhi lucidi, strinse a sé la figlia per l’ultima volta e le sussurrò qualcosa baciandola sulla fronte, mentre l’uomo voltava il cavallo.
La giovane montò sul cocchio accanto a lui e si sedette con il sacco imprigionato fra le gambe e il capo reclinato come una condannata avviata al patibolo. Appoggiata alla soglia d’entrata, la madre rimase a osservarli, mentre rimpicciolivano sempre di più nel viola del crepuscolo.
La sera del giorno seguente giunsero alla villa padronale di Don Felipe Duarte Velasco, adagiata sul fianco della collina di Chipinque, a sud di Monterrey. L’imponente edificio si sviluppava su tre piani e dominava la valle sottostante sommersa da rigogliose piantagioni. Un viale di ghiaia immacolata delimitato da altissime palme reali conduceva a un ricco giardino fiorito, in mezzo al quale si elevava un’elaborata fontana in pietra lavica a forma di conchiglia. L’ingresso principale della villa si trovava dietro la fontana ed era abbellito da tre ampie arcate sostenute da capitelli corinzi, che poggiavano su eleganti colonne di marmo bianco. Il calesse infilò un vialetto alla destra della grande casa padronale e si fermò davanti alle scuderie.
Un uomo prese in consegna il cavallo, mentre la ragazza seguiva il suo accompagnatore verso gli edifici della servitù. Camminarono sotto il portico di un lungo fabbricato, sul quale si affacciavano diverse porte; l’uomo si fermò davanti a una di queste ed estrasse un pesante mazzo di chiavi. Fece entrare la ragazza in una minuscola stanza con un armadio alla parete e un letto sotto la finestrella chiusa da un’inferriata. Un piccolo specchio, un tavolo e una sedia completavano l’arredamento di quell’ambiente angusto.
«Questa è la tua camera e queste sono le chiavi. Più tardi ti porteranno da mangiare. Inizierai a lavorare da domani mattina e ti spiegheranno tutto quello che c’è da fare.»
La ragazza rimase ad ascoltarlo senza porre alcuna domanda, poi l’uomo uscì e lei si sedette ai piedi del letto. Passò la mano sulle lenzuola ruvide e volse lo sguardo intorno: non c’era poi granché da vedere, ma tutto le sembrava molto più pulito del tugurio nel quale era nata e aveva vissuto fino a quel momento.
Non aveva mai visto una villa così bella e maestosa e non avrebbe nemmeno potuto immaginarla, perché non si era mai mossa dal suo miserabile villaggio di fango e paglia. Si distese sul letto guardando il soffitto e cercò d’immaginare cosa avrebbe dovuto fare il giorno dopo, ma non vi riuscì. Dopo qualche minuto le pareti della cameretta scomparvero come d’incanto e le passarono davanti agli occhi le immagini della sierra, la mole del Cerro San Rafaèl, i boschi di pini e l’acqua fresca dei torrenti, i suoi fratellini che correvano nel villaggio, la madre che preparava le tortillas, il padre divorato dalla malattia e la disperazione di tutto il suo piccolo mondo contadino.
Nei giorni seguenti la ragazza fu impiegata nella grande lavanderia della tenuta di Don Felipe Duarte. Qui non venivano lavati solo i capi della famiglia padronale, ma anche quelli del personale di servizio. Erano esclusi solo i contadini, che ogni giorno si spezzavano le braccia e la schiena nei campi.
Il luogo si trovava a cinquecento metri dal corpo principale della villa e sfruttava le acque di una sorgente perenne che scaturiva dai fianchi della collina di Chipinque. I vestiti sporchi e le lenzuola venivano immersi in due grandi vasche, riempite e svuotate di acqua calda e liscivia a ogni nuovo ciclo. Azionando due piccoli torni collegati a un sistema di pale, le lavandaie facevano ruotare i panni in ammollo e li liberavano dalla terra e dallo sporco più grossolano. Una volta estratti dalla vasca, i capi venivano strizzati a mano e portati al lavatoio presso il torrente dentro delle grandi ceste, dove altre donne li prendevano in consegna e provvedevano a stenderli su ampi lastroni di granito. Qui passavano il sapone sulle macchie residue, strofinando e sbattendo i panni contro la nuda roccia. Dopo un ultimo risciacquo nell’acqua corrente, tutti i capi venivano spemuti mediante un ingegnoso sistema di rulli e quindi stesi al sole ad asciugare sugli stendibiancheria.
Visti da lontano, sembravano un immenso raduno di uccelli dalle ali bianche.
La ragazza condivideva il lavoro con altre compagne più grandi di lei provenienti dai dintorni. Un po’ alla volta le vennero affibbiati altri lavori domestici, tra i quali le pulizie di casa, la cura delle piante e la preparazione dei pasti per i braccianti impiegati nelle piantagioni di mais e canna da zucchero.
Da quando era stata presa, lavorava come una schiava dall’alba al tramonto a ritmi massacranti e senza un solo minuto di pausa. Era la più giovane e gli altri membri della servitù la oberavano di qualsiasi incombenza, anche della più insignificante. Alla sera crollava sul letto esausta, scivolando in un sonno profondo e senza sogni.
Una mattina, mentre era impegnata a lavare il pavimento del sottoportico, vide giungere un piccolo drappello di uomini a cavallo. Avevano l’aria stanca e i vestiti logori e impolverati, come se fossero stati sulle montagne per diverse settimane. Trascinavano due muli, sui basti dei quali erano state impacchettate delle pelli, scuoiate di fresco. Tra le zampe dei cavalli si rincorrevano festosi e scodinzolanti cinque segugi dal manto pezzato e dagli occhi spiritati, le bocche aperte e le lingue a penzoloni. Non appena i cacciatori si furono fermati davanti alla villa, tutti abbandonarono le occupazioni del momento e si fecero loro attorno, incuriositi. Circondati dalla piccola folla, un paio di uomini slacciarono le cinghie che immobilizzavano la soma e la tirarono giù dal mulo di testa. Il pesante fardello cadde a terra con un tonfo sollevando una nuvola di polvere bianca.
«Bentornato Don Felipe! Com’è andata la caccia?» chiese il carrettiere andando incontro al capo della spedizione.
«Non poteva andare meglio, Antonio! Un orso e due lupi.»
L’uomo afferrò un’estremità del telo e lo sollevò a metà, scoprendo il carico. Un paio di bambini fecero un salto all’indietro spaventati quando videro sbucare la testa dell’orso. L’animale aveva gli occhi già svuotati dalle mosche e la lingua che fuoriusciva dalle fauci, rosa e spessa come una fetta di prosciutto. Con il pollice Don Felipe sollevò il labbro superiore dell’animale per metterne in mostra i canini giallastri.
«Un maschio di quasi duecento chili! Lo abbiamo scovato sopra Rancho Carvajal. Purtroppo mi ha fatto fuori due cani, Reina e Copito. Non sarà facile rimpiazzarli.»
«E i lupi invece?»
«Erano in coppia. Un vero colpo di fortuna. Si sono traditi…»
«In che senso, patròn?»
L’uomo non rispose e sorrise invece alla figlia Esmeralda, che era ai suoi piedi e fissava ancora intimorita la testa nera dell’orso. S’inginocchiò davanti a lei, le prese il mento e glielo sollevò delicatamente, guardandola dritta negli occhi.
«Ehi piccola, non saluti il tuo papà?»
La bimba lo fissò con gli occhioni scuri e gli gettò le braccia al collo. L’uomo allora la prese in braccio e si avviò con lei verso il secondo mulo.
«Ti ho portato una piccola sorpresa» le sussurrò dandole un bacio sulla nuca.
«Che sorpresa papi?»
«Ora vedrai, sono sicuro che ti piacerà.»
La rimise giù e aprì una cesta che era fissata sul basto. V’introdusse la mano e tirò fuori un lupacchiotto di appena tre settimane tenendolo per la collottola.
«Che mi dici… ti piace?»
La bimba sgranò gli occhi e rimase a bocca aperta, incapace perfino di emettere un suono. Il cucciolo era una palla di pelo grigio e aveva gli occhi socchiusi. Appena iniziò a guaire, l’uomo lo posò per terra. Fece qualche passo incerto con la piccola coda ripiegata tra le zampe, poi non sapendo più dove andare, si fermò tra Don Felipe e la bambina e cominciò a tremare come una foglia.
«Lo posso toccare?»
«Certo Esmeralda, è tuo, puoi tenerlo fino a quando è piccolo.»
«E poi?»
«Poi lo metteremo in una gabbia, ma potrai continuare ad andare a trovarlo e a dargli da mangiare.»
Don Felipe accarezzò la figlia sul capo e la lasciò giocare con il lupacchiotto.
Prese il cavallo per le briglie e si incamminò verso le scuderie. Mentre passava davanti al porticato, notò la ragazza con il mocio ancora in mano. Rallentò il passo fino a fermarsi e le lanciò una lunga occhiata. Turbata e presa alla sprovvista da quello sguardo così insistente, la giovane immerse il mocio nel secchio e riprese a fregare il pavimento con energia. Poi con la coda dell’occhio, lo vide allontanarsi verso le stalle.
«Gli sei piaciuta, chica!»
La ragazza sobbalzò di paura. Una delle serve più anziane le era passata accanto e le aveva sussurrato all’orecchio in modo lascivo. La guardò proseguire lungo il sottoportico mentre calpestava incurante con i piedi sporchi il pavimento ancora bagnato.
L’azienda agricola di Don Felipe Duarte veniva considerata a ragione la più importante e fiorente dell’intero Nuevo Leòn e si estendeva a perdita d’occhio dalle pendici della Sierra Madre fino alla periferia settentrionale di Monterrey. I contadini alle sue dipendenze, quasi tutti indigeni, superavano il centinaio e vivevano con le loro famiglie in piccoli agglomerati di paglia e fango, dispersi all’interno del latifondo. Il salario era costituito dal vitto e dal permesso di residenza, che la famiglia padronale concedeva loro da oltre due secoli. In realtà quelle terre erano appartenute agli indios da millenni e sarebbero spettate loro di diritto, ma nessuno sembrava essersi mai posto il problema.
Per la grande estensione della tenuta, a ogni nucleo famigliare era stato assegnato un determinato settore della piantagione ed era frequente che le persone nascessero, campassero e morissero in un raggio di appena cinque chilometri. La maggior parte di essi non era mai uscita dai confini della proprietà, nemmeno per un giorno. La popolosa e moderna città di Monterrey, a pochi chilometri da lì, sembrava remota ed esotica quanto Città del Messico.
Le condizioni di lavoro nelle piantagioni di canna da zucchero prosciugavano rapidamente il fisico di un uomo ed erano pochi i braccianti che riuscivano a superare i cinquant’anni. Pur costretti a una vita di semi schiavitù, scandita dai cicli stagionali delle piante da cui dipendevano, i contadini di Chipinque non avevano mai osato ribellarsi ai loro antichi padroni.
Gli altri membri del personale se la passavano decisamente meglio dei braccianti. Cuochi, cameriere, stallieri, domestiche, vaqueros, sorveglianti e giardinieri – pur usufruendo degli alloggi e del cibo della tenuta – erano pagati regolarmente e alcuni riuscivano a mandare un po’ di denaro alle famiglie d’origine.
L’immensa proprietà di Don Felipe Duarte assomigliava a un piccolo regno, un feudo impenetrabile alle idee rivoluzionarie e al progresso tecnologico, che invece avanzavano a ritmi serrati appena oltre il mare verde dei suoi canneti.
In un torrido pomeriggio di luglio, mentre stava appendendo le lenzuola sugli stendibiancheria, Antonio, il carrettiere che l’aveva prelevata da casa, si avvicinò alla ragazza e le disse che il padrone voleva vederla. Lei lo seguì verso il retro della villa ed entrarono nella casa di caccia, un edificio staccato dal resto del complesso residenziale. La fece attendere nell’atrio, quindi la introdusse nel salone al cospetto del signore e li lasciò da soli.
Don Felipe sedeva dietro una pesante scrivania di mogano. Indossava una camicia bianca con il colletto aperto e le maniche arrotolate sotto i gomiti. Era un uomo sulla cinquantina con i capelli brizzolati e un leggero pizzetto che incorniciava delle labbra sottili e autoritarie. Sulle pareti spiccavano diversi trofei di caccia, soprattutto teste di animali imbalsamati e uccelli rapaci con le ali spiegate e il becco aperto, pronto a ghermire.
La ragazza mosse alcuni timidi passi verso il padrone, poi si fermò imbarazzata al centro della stanza. L’uomo la studiò in silenzio per alcuni istanti, quindi prese una scatola di legno davanti a sé, l’aprì e tirò fuori un sigaro. Mentre l’accendeva, continuava a fissarla tra le volute di fumo azzurro.
«E così, tu sei Juana, quella nuova… dimmi Juana, come ti trovi qui a Chipinque?»
«Mi trovo bene, signore.»
«Mi fa piacere. Sei molto giovane, quanti anni hai?»
«Diciassette, signore.»
«Diciassette… E sei mai stata con un uomo?»
La ragazza trasalì a quella domanda così personale e del tutto inattesa, poi con un filo di voce e un lieve cenno di diniego del capo, rispose di no. Don Felipe si alzò dalla poltrona e si sedette sulla scrivania di fronte a lei. Tirò una profonda boccata socchiudendo l’occhio destro, quindi la fece voltare e la osservò da dietro: era più alta delle ragazze della sua età e portava i lunghi capelli neri raccolti in una coda di cavallo.
L’uomo posò il sigaro sul portacenere, si alzò dalla scrivania e le sciolse i capelli che le ricaddero sulle spalle scendendo fino a metà schiena. La ragazza tremava di paura, ma lo lasciò fare. Don Felipe la girò nuovamente fissandola dritta negli occhi e con l’indice della mano destra ne percorse il delicato profilo, dalla fronte e giù per il naso, fino alle labbra. Gliele dischiuse e introdusse il dito nella bocca che si aprì leggermente. Poi la ragazza indietreggiò all’improvviso e rimase con il capo chino, senza avere il coraggio di alzare lo sguardo.
«Spogliati!»
L’ordine arrivò brusco e violento, come una fucilata a bruciapelo. La giovane spalancò gli occhi terrorizzata, incapace di muoversi.
«Allora mi spoglio io, uno dei due deve pur farlo.»
L’uomo si slacciò la cintura, abbassò i pantaloni fino alle ginocchia e rimase con il membro già duro in mano.
«Che c’è figliola… È la prima volta che ne vedi uno? Non male, eh?»
Juana scostò il capo di lato per non guardare.
«Su, toccalo!»
Lei sussurrò qualcosa, reprimendo una smorfia di disgusto.
L’uomo allora le afferrò il polso, glielo torse e la trascinò a sé; la ragazza lottò e cercò di resistergli, ma alla fine fu costretta all’obbedienza. Don Felipe le strappò i vestiti di dosso e le scoprì la schiena e i glutei. Si sputò sulle mani e lubrificò il pene, eretto come un pugnale, poi la sbatté contro la scrivania e la infilzò da dietro, strizzandole i seni con entrambe le mani.
Juana sentì il sesso dell’uomo che la lacerava e un dolore acuto e profondo la penetrò come una lama fino al cervello. Gridò con le lacrime agli occhi e questo eccitò ancor di più Don Felipe, che a ogni spinta le ansimava sul collo come un animale feroce, affondando nel sangue. Prima di venire le afferrò i capelli e glieli tirò fin quasi a strapparli. La ragazza urlò di terrore inarcando la schiena e l’uomo si staccò da lei, scaricando il seme sulle sue natiche con un rantolo.
Don Felipe rimase per alcuni istanti in piedi in mezzo alla stanza, barcollante e con le brache calate, ormai svuotato. Poi si ripulì con un fazzoletto e si accasciò sulla poltrona, riaccendendo il sigaro che aveva abbandonato nel portacenere. Afferrò una bottiglia di tequila e bevve un lungo sorso, asciugandosi la bocca con il dorso della mano.
Continuava a fissare la ragazza davanti a sé, che ancora non si era mossa, nuda e tremante, con le mani appoggiate alla scrivania e il viso celato dalla lunga chioma arruffata.
«Non sei stata presa qui a Chipinque solo per lavare la biancheria e lucidare i pavimenti… La prossima volta ti voglio più partecipe. Ora rivestiti e vattene.»
Nelle settimane successive Juana fu convocata ancora da Don Felipe, che ne approfittò regolarmente fino a metterla incinta. Quando glielo rivelò, l’uomo non mostrò alcun interesse o turbamento, ma le proibì di andarlo a raccontare in giro. In realtà si era trattato di un incidente che Don Felipe avrebbe preferito evitare. Sebbene tutti fossero a conoscenza delle sue continue relazioni extraconiugali con serve e prostitute, un figlio illegittimo poteva diventare una presenza imbarazzante agli occhi di sua moglie e del resto della famiglia. Decise di sbarazzarsene, ma nel frattempo continuò ad abusare di lei in mille modi.
Una notte, al ritorno da Monterrey, Don Felipe bussò alla porta della ragazza. Lei si svegliò di soprassalto e andò ad aprire, turbata, sbirciando dalla soglia. Le apparve un fantasma senza volto, la nera silhouette del padrone con il disco della luna alle spalle. Fu investita da una zaffata di tabacco e alcol.
«Muoviti, vieni con me!»
«Dove andiamo?» si azzardò a chiedere.
«Voglio mostrati una cosa.»
Juana uscì, rabbrividendo di freddo. A piedi scalzi e con le braccia conserte sul petto, seguì l’uomo e il suo cavallo, diretti verso le stalle.
Don Felipe accese lo stoppino del lume a petrolio posto all’interno, dietro al grande portone di legno a due ante e condusse il cavallo al suo box.
Juana si era fermata all’entrata e non osava proseguire. Osservò l’uomo staccare la sella e la testiera dal cavallo e riporli dentro un armadio che già conteneva spazzole, striglie e altri finimenti. Poi Don Felipe si voltò verso di lei.
«Perché te ne stai lì? Su, entra, non aver paura!»
Juana mosse i primi passi dentro la stalla. L’odore penetrante degli animali e dei liquami nei canali di scolo le invase le narici. Sentiva il respiro potente e il calore emanato dai quadrupedi, che la fissavano con occhi neri e lucidi come biglie di vetro. Le loro vene in rilievo sotto il pelo raso risalivano dalla pancia al collo e sembravano il corso di tortuosi fiumi su una pergamena antica.
«Cosa c’è? Mai visti tanti cavalli tutti insieme?»
«No, patròn.» La ragazza si guardò intorno, posando infine gli occhi su una femmina dal manto grigio e leggermente pomellato sul dorso. Il volto dell’uomo, alterato dall’alcol, si illuminò.
«Quella giumenta è il gioiello di questa scuderia! Pura razza andalusa. Non esiste nessuna bestia al mondo che sappia eseguire il passo di questi cavalli. Per la verità non è un passo, ma una vera danza, un omaggio di fedeltà e sottomissione al suo cavaliere. Si chiama Malinche, un nome importante, ricco di storia… Lo sai chi era Malinche?»
Juana fece di no con il capo e Don Felipe le si avvicinò con un sorriso di scherno.
«Per forza, come puoi saperlo?»
Con il dorso delle dita le accarezzò il profilo del viso, sfiorandole gli zigomi e le gote e poi sempre più giù, fino a indugiare sulla curvatura del seno.
«Malinche è vissuta quattro secoli fa. Fu venduta dai genitori a dei mercanti maya che poi la regalarono a Hernan Cortès, il conquistatore di questo paese, e ne divenne l’amante fedele. Dicono che fosse bella come una dea, la chiamavano la princesa india. Dopo alcuni anni però, Cortès se ne sbarazzò e la diede in sposa a uno dei suoi uomini, un hidalgo di nome Jaramillo. Poi non si sa che fine fece… la sua storia termina qui.»
Juana guardava l’uomo che aveva inclinato la testa e ora la fissava con occhi di ghiaccio. All’improvviso lo vide staccarsi da lei e calarsi le brache. La denudò e la spinse dentro il box dell’andalusa, che alzò la testa e mosse alcuni passi all’indietro, spaventata. La ragazza finì sopra una balla di fieno e affondò il viso nella paglia secca mentre l’uomo estraeva dall’armadietto un vaso di cera d’api per i finimenti. Con le dita lorde di grasso, le infilò il lubrificante nell’ano preparandosi a penetrarla. L’ultima cosa che Juana vide prima di chiudere gli occhi, fu l’immagine di sé riflessa nell’occhio lucido del cavallo, che la guardava impassibile con in bocca un ciuffo di fieno.
Una mattina ai primi di novembre, Don Felipe convocò Antonio.
«La ragazza è gravida, è già al quarto mese e non posso più tenerla. La voglio via da qui.»
«Avete già qualche idea, Don Felipe? Volete che la riporti alla sua famiglia sulla sierra?»
«Meglio di no, piuttosto vedi quanto ti dà quello stronzo di Osvaldo, giù a Monterrey.»
«Non molto visto che è incinta e dovrà pagare un dottore per farla abortire…»
«E quanto chiedono quei macellai?»
«Non ne ho idea, però ci sono dei metodi naturali per farle perdere la creatura.»
«Non mi intendo di stregonerie; vedi tu, contratta sul prezzo. Non voglio meno di quanto l’ho pagata, intesi? E se riesci a spuntare un prezzo migliore, la differenza è tua. Entro domani dovrà essere fuori di qui.»
La ragazza venne svegliata in piena notte, Antonio le ordinò di raccogliere tutte le sue cose e di infilarle in un sacco. Salirono sul calesse e si avviarono giù dalla collina di Chipinque, in direzione di Monterrey. Attraversarono un fitto bosco, che ogni tanto si apriva e permetteva di scorgere verso nord le luci gialle della grande città. Juana provò a chiedere più volte dove stessero andando e perché, ma l’uomo si limitava a ripetere semplicemente «Monterrey».
Procedettero lungo una strada tortuosa ma piuttosto agevole, rischiarata appena dal lampione che penzolava dietro al cavallo. Attorno a quell’unico fanale svolazzavano come elettroni impazziti miriadi di insetti e farfalle notturne, attirati dalla luce.
Dopo un’ora, raggiunsero le prime case della periferia, edifici bassi e miserabili tra campi incolti e piccole discariche, dentro le quali rovistavano mute di macilenti cani randagi. Il calesse s’infilò in un dedalo di viuzze che conducevano alla zona orientale della città, dove alcune prostitute sostavano negli androni scuri dei portoni in attesa dei clienti e li guardarono passare.
All’altezza di una casa con un piccolo balconcino al piano superiore, l’uomo fermò il cavallo, scese e bussò. Dopo un po’ si sentì scorrere la barra di un pesante chiavistello e si materializzò un sottile spiraglio di luce fra lo stipite e la porta. Juana era ancora raggomitolata sul calesse con il sacco fra le gambe e non udì le parole che i due si scambiarono; poi il carrettiere le fece cenno di scendere, la porta si aprì quasi del tutto ed entrambi scivolarono dentro la casa come due ombre furtive.
Una donna di mezza età, brutta come una strega, fece loro strada lungo una breve scala interna e li condusse al piano superiore. Entrarono in una stanza con in mezzo un grande letto e un paio di vetrine polverose e ingiallite, dove erano riposti strani strumenti metallici che Juana non aveva mai visto prima di allora.
Venne assalita dalla paura e chiese ad Antonio: «Che cos’è questo posto?»
«Una specie di infermeria.»
«E cosa ci facciamo qui? Perché mi hai portato da questa donna?»
«Dovremo fare un piccolo intervento, non ti preoccupare, non ti accadrà nulla di male. Devi solo stare calma e fra un po’ sarà tutto finito.»
La ragazza gli piantò gli occhi addosso, e Antonio trasalì. Nel suo sguardo non c’era solo la paura per ciò che le sarebbe accaduto da lì a poco, ma una furia repressa e incontenibile per quell’ultimo, efferato oltraggio.
All’improvviso si udì un clack nella toppa della serratura. La donna aveva appena chiuso l’uscita e si era infilata addosso la chiave. Juana si precipitò verso la porta, decisa a sfondarla, ma Antonio fu più rapido e la bloccò a metà strada. La poveretta prese a urlare e a tempestare di pugni e calci il carrettiere, che faticò a immobilizzarla e dovette torcerle il polso, costringendola a terra. Nel frattempo, l’ostetrica aveva riempito una siringa con una buona dose di morfina. Con un gesto deciso gliela iniettò nella vena del braccio, ancora torto dietro la schiena. Mentre l’alcaloide entrava in circolo, Antonio teneva la ragazza inchiodata al pavimento con tutto il suo peso. Attesero alcuni minuti che il sedativo facesse effetto, quindi la liberarono e l’adagiarono sul lettino.
Quando videro che era completamente rilassata, si ritirarono in disparte per parlare.
«La ragazza è già al quarto mese, perché non me l’avete portata prima?», chiese la donna.
«Non può più abortire?»
«Certo che può, ma è rischioso. Non posso più usare l’acqua saponata e la segale cornuta, il feto è già troppo grosso.»
«E allora?»
«Devo tagliare il feto a pezzi per estrarlo e poi raschiare internamente.»
«Fai quello che devi fare.»
«È un pericolo anche per lei… Sei sicuro di non poterglielo lasciare?»
«Devo venderla! Chi diavolo me la prende con un marmocchio in pancia?»
La narcotizzarono ancora, facendole bere una tisana che sapeva di muschio e muffa; poi la donna mise a bollire una pentola d’acqua, dentro la quale immerse una specie di forcipe, delle pinze e un cucchiaino aguzzo e ricurvo. Appena il narcotico iniziò a fare effetto, l’uomo allargò le gambe di Juana e l’ostetrica le applicò lo speculum per divaricare le pareti della vagina; quindi introdusse il cucchiaino e iniziò l’operazione di embriotomia.
L’intervento durò meno di un’ora. Ai piedi del letto un catino di ferro smaltato raccoglieva i pezzi sanguinolenti di un minuscolo corpicino, che da lì a poco sarebbe stato divorato dai cani.
Per meglio valutare le sue condizioni di salute, Juana rimase a riposo nella casa della donna. Fu divorata dalla febbre e da dolori lancinanti, al punto che l’ostetrica iniziò a temere un inizio di setticemia. L’accudì per alcuni giorni, dopodiché Juana iniziò a stare meglio e la febbre scomparve quasi del tutto.
Una settimana più tardi Antonio passò a riprenderla, pagò la donna e condusse la ragazza sulla sponda meridionale del Rio Santa Catalina, che tagliava in due la città di Monterrey. Entrarono in una specie di bar che puzzava di fumo e di chiuso. All’esterno l’ingresso era sormontato da un’insegna rossa con raffigurato un serpente a sonagli e la scritta El Cascabél.
A quell’ora del mattino non c’erano clienti, solo un cameriere che stava lucidando i bicchieri dietro un lungo bancone di legno scuro, sormontato da un enorme specchio fumè. Il resto della sala era occupato dalla pista da ballo e da una serie di divanetti arabescati divisi da piccoli separé. Una scala a chiocciola portava al piano superiore e alle camere delle ragazze che lavoravano nel night.
Il carrettiere chiese di Osvaldo, il padrone del locale, che arrivò di lì a poco, scendendo le scale a torso nudo e con un cigarrillo fra le dita.
«Toh, chi si rivede… eri sparito da un pezzo.»
«Sono ancora vivo, come vedi.»
«E quello stronzo del tuo padrone, perché non viene più a trovarmi?»
«Verrà. Nel frattempo ti manda i suoi saluti e… questo fiorellino della sierra.»
Osvaldo guardò la ragazza che se ne stava seduta in disparte su uno dei divanetti.
«Quanti anni ha?»
«Diciassette, ma Don Felipe l’ha già svezzata a dovere.»
«Ne ho già troppe di ragazze Antonio, non so più dove metterle.»
«Beh, manda via qualcuna e prenditi questa. Ti consiglio di guardarla bene.»
Questa è la fine dell’anteprima gratuita.
Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile