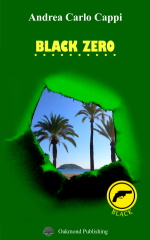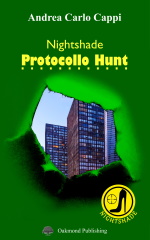Medina: Malastrana di Andrea Carlo Cappi –
Il mio nome è Carlo Medina e mi occupo di intrighi e di omicidi. Non di risolverli. Di organizzarli.
- Titolo: Medina: Malastrana
- Autore: Andrea Carlo Cappi
- Lingua: Italiano
- Formati: kindle, copertina flessibile
- Editore: Oakmond Publishing (2022)
- Generi: Spionaggio, Romanzo, Thriller, Giallo, Narrativa
Tra i migliori clienti di Carlo Medina e della sua agenzia di eliminatori figura una compagnia farmaceutica italiana, ora sul punto di essere acquisita da un colosso tedesco del settore. Mentre lui rimuove a suo modo ogni ostacolo all’operazione, qualcuno sequestra uno a uno i manager della società. Medina si trova coinvolto in un intrigo molto più complesso del previsto, in cui entrano in gioco un magnate russo del petrolio e la guerriglia cecena, insieme a vecchi e nuovi servizi segreti dell’Est. Da Milano a Praga, per molti la morte sarà l’unica medicina.
Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile
Comincia a leggere qui gratuitamente l’incipit del libro
Medina: Malastrana:
Preludio
Venti anni prima, maggio 1990
Viktor Klimenko aprì gli occhi. Non riusciva a ricordare dove si trovasse. Viaggiava spesso, si svegliava ogni mattina in un luogo diverso e tardava sempre qualche secondo a orientarsi. Allora cercava un punto fermo: la sua vecchia, robusta valigia marrone, che la sera prima aveva lasciato appoggiata su un tavolino, o su una sedia, o su una scrivania…
Ma il luogo in cui si trovava in quel momento non assomigliava alla sua stanza d’albergo a Malá Strana. Niente valigia. Niente scrivania. Niente quadretti alle pareti, niente tendine di velluto polveroso alle finestre. Niente finestre.
Poi i ricordi riaffiorarono: la sensazione di essere seguito sul Karlúv Most, il tentativo di seminare quelli che era certo fossero due colleghi (ma forse ora doveva considerarli ex colleghi), le mani che lo afferravano, l’ago della siringa nel collo mentre cercava rifugio nei bagni di un caffè in namĕsti Franze Kafky. E il buio che lo aveva avvolto da quel momento fino a pochi istanti prima.
Non che il luogo in cui si trovava adesso fosse molto luminoso, come non lo era il suo immediato futuro. Lo avevano preso, quindi dovevano avere anche la borsa con i documenti. Per cui ora sapevano esattamente cosa stesse cercando di fare.
Sapevano che cos’era diventato.
In verità Viktor Klimenko non considerava se stesso un traditore. Non intendeva bruciare alcuna operazione in corso, si era limitato a cercare di guadagnare qualcosa vendendo segreti ormai fuori moda. Gli americani gli sarebbero stati grati se li avesse aiutati a identificare talpe ormai non operative da dieci o vent’anni. Verità che agli occidentali servivano per risolvere alcuni loro conti interni rimasti in sospeso, ma che ormai non avrebbero potuto danneggiare l’Unione Sovietica.
Niente di pericoloso, dunque, ma per Viktor Klimenko avrebbe significato rifarsi una vita all’estero, lontano dai burocrati che stavano liquidando le attività spionistiche di Mosca in nome della perestrojka. Il Muro di Berlino era stato abbattuto, i paesi del blocco sovietico si liberavano dei vecchi governi.
La Guerra Fredda è finita, andate in pace.
Lo spionaggio era morto, dicevano. E con quel pretesto a Mosca si disfacevano dei fossili come lui, al solo scopo di prenderne il posto nel nuovo regime o in quello successivo. Lui aveva avuto la sua grande occasione di batterli sul tempo.
Ma ora, dopo la cattura, poteva dire addio a tutte le sue illusioni. In qualche ufficio del quartier generale di Yazenevo c’era chi voleva mantenere una finzione di rigore e di efficienza mentre tutto andava a rotoli. E qualcuna delle talpe a Langley doveva essere tuttora operativa: nessuno al di fuori della CIA poteva sapere del suo viaggio a Praga. Solo in quel modo i suoi ex colleghi potevano avere saputo dell’imminente defezione, arrivando a catturarlo prima che riuscisse a consegnare la valigetta al suo contatto americano.
Klimenko si guardò intorno. Si trovava in uno stanzone poco illuminato. Era disteso su una dura superficie orizzontale. Intorno a lui c’erano altre lastre di granito sulle quali giacevano corpi immobili, le cui sagome erano riconoscibili sotto le lenzuola ingiallite che li coprivano da capo a piedi.
Un obitorio?
Tipico umorismo del KGB. Di sicuro volevano interrogarlo per scoprire con chi dovesse prendere contatto a Praga. Quindi non potevano ucciderlo, non subito. Ma volevano farlo sentire come se fosse già un cadavere, in modo che la confessione gli sembrasse l’unica speranza per tornare tra i vivi.
Scostò il lenzuolo che lo copriva solo in parte, si mise a sedere sulla lastra e appoggiò i piedi a terra. Indossava ancora la giacca e i pantaloni di qualche ora prima. Cravatta, cintura, scarpe, orologio e portafogli erano spariti.
Riusciva a camminare, il che era una buona notizia, anche se aveva un forte mal di testa e le gambe lo reggevano a fatica. Sentiva ancora il bruciore dell’ago nel collo, ma non aveva la sensazione che gli avessero fatto altre iniezioni. Gli avevano somministrato una sola dose di narcotico, quindi non doveva avere fatto molta strada. Se non lo avevano caricato su un jet per portarlo a Mosca come posta aerea, era probabile che si trovasse ancora in Cecoslovacchia.
Su una parete dello stanzone si apriva una porta che dava su un corridoio, in fondo al quale brillava una luce più intensa di quella che illuminava l’obitorio. Viktor si incamminò in quella direzione.
Si appoggiò a uno stipite cui mancava la porta. Un tubo a fluorescenza sul soffitto illuminava un uomo in camice bianco seduto al centro di una saletta. Sul tavolino di fronte a lui c’era una scacchiera con una partita in corso. La sedia dall’altra parte era vuota: l’uomo in bianco giocava a scacchi da solo.
Oppure con la Morte, ma la vedeva solo lui.
«Siamo a Zauberberg?» gli domandò Viktor.
L’uomo in bianco annuì.
Il russo sospirò. Aveva indovinato. Si trovava ancora in Cecoslovacchia, o più esattamente nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, come si chiamava da circa un mese. Ma tanto valeva che lo avessero condotto in un gulag siberiano o nei sotterranei della Lubianka.
L’installazione segreta denominata Zauberberg, per quanto si trovasse poco lontano da Praga, era una porta sul Nulla. Viktor non aveva sentito dire di nessuno che ne fosse mai uscito vivo.
«Torna a dormire, compagno», suggerì l’uomo in camice. Poi spostò uno dei pezzi bianchi sulla scacchiera.
Viktor non aspettò di vedere se qualche pezzo nero si muovesse a sua volta in risposta. Poteva essere di cattivo auspicio. Ripercorse il corridoio fino all’obitorio e si distese sulla sua lastra, con la certezza che di lì a qualche giorno sarebbe stato immobile come gli altri ospiti, con un lenzuolo a coprirgli la faccia.
Parte prima – TRANSYLVANIA EXPRESS
Sui vetri vedo il mio riflesso in abito scuro. Le porte a vetri scorrono, facendosi da parte. Io entro e attraverso la hall dell’albergo con passo sicuro fino alla reception.
Il portiere mi dà la chiave della stanza. Ero convinto che mi avessero assegnato la 218, ma dall’anello pende un rettangolo di plastica su cui si legge 4F2.
«È una delle suite all’ultimo piano», mi spiega. «Per un ospite come lei…»
Sul banco della reception c’è un giornale, aperto su una mia fotografia. Il mio nome è su un manifesto appeso in una bacheca. Sanno tutti chi sono e che cosa sono venuto a fare.
Entro in ascensore. Dalla chiave pensavo che la suite fosse al quarto piano, ma sulla tastiera leggo che le stanze con quella numerazione sono molto più in alto. La cabina ci mette un po’ ad arrivare. Le porte automatiche si aprono su un corridoio luminoso e moderno, diverso da quelli dei piani inferiori, scuri e con la moquette usurata. Qui dalle vetrate entra la luce del sole, dando una sensazione di bianco e di calore.
Leggo i cartelli alle pareti e una freccia mi indica che stavo sbagliando direzione: la mia suite non è a sinistra, ma a destra, di là da una porta a vetri. Inserisco nella fessura della porta la scheda magnetica – non la chiave – che mi è stata data alla reception senza che nemmeno me ne accorgessi. Si accende una luce verde e la serratura scatta.
La stanza è in perfetto ordine e le tende scostate lasciano entrare il sole. Su una scrivania ci sono altri giornali con sopra la mia fotografia.
La mia esibizione dev’essere molto attesa.
Vado subito sul balcone: sono più in alto di quanto pensassi e vedo sotto di me il grande anello della plaza de toros. C’è già folla sulle gradinate. Mi stanno aspettando. Immagino me stesso con indosso un rilucente vestito rosso e oro, mentre una bestia scalpitante dal manto nero mi passa accanto, quasi sfiorandomi con le corna acuminate, e la capa mi volteggia intorno tra gli applausi della folla. Ma questo è ciò che dovrò fare tra poco, la sfida che devo ancora affrontare, quello che gli spettatori si attendono da me.
Suona il telefono. Una voce maschile, preoccupata, mi dice: «Che cosa aspetti? Sono già le sei meno un quarto!»
Guardo l’orologio. In realtà segna le cinque e quaranta, ma ho appena venti minuti per prepararmi e scendere nell’arena. Un momento… A che ora cominciano le corride? Alle cinque della sera? No, quello era García Lorca. Alle sei? O alle cinque e mezzo? Che ora era scritta sul manifesto, giù alla reception? E il mio vestito da matador è nel bagaglio, che è stato portato – ne sono sicuro – nella stanza 218.
Il telefono squilla di nuovo.
E in quell’istante mi rendo conto che io non sono un torero, che non sono mai sceso nell’arena in vita mia, che non so affatto come si combatte un toro e che durante la corrida andrò incontro a morte certa.
Io so uccidere solo le persone.
È per questo che sono qui.
1
Segrate (Milano), prime ore di venerdì 30 luglio 2010
«Il tuo cellulare», disse Barbara. «Tre squilli, poi altri tre squilli.»
Carlo Medina aprì gli occhi e si mise a sedere. Si era addormentato senza accorgersene sul letto della stanza 218 del Cielhotel. Nello specchio vide un uomo dai capelli scuri con qualche striatura grigia qua e là; baffi ancora neri, che lo facevano assomigliare a Charles Bronson; occhi castani, svegli e attenti dietro gli occhiali che gli servivano solo per leggere. L’adrenalina stava facendo il suo dovere: pochi secondi e già si sentiva perfettamente lucido.
Chiuse il libro senza segnare la pagina, si tolse gli occhiali e li infilò nel taschino della giacca del completo scuro di Trussardi. Il cellulare aveva suonato tre squilli, poi altri tre squilli: era il segnale.
Amanda aveva fatto il suo dovere.
Medina fece un cenno di saluto a Barbara, uscì dalla stanza e raggiunse le scale. Al piano di sopra camminò silenzioso sulla moquette del corridoio fino alla porta della camera 327. Un attimo dopo gli aprì una creatura pallidissima, con lunghi capelli neri lisci, occhi di un azzurro irreale e labbra carnose dipinte di rosso. Indossava solo un esiguo completino intimo di pizzo.
«Sei tu Amanda?» Lui la vedeva per la prima volta: era stato Vitiello a procurarla e Ray a portarla all’albergo.
Lei annuì.
Medina entrò, chiuse la porta e scandagliò la stanza, identica a quella in cui si trovava lui fino a poco prima a parte il televisore sintonizzato sul canale porno dell’albergo. Il film in onda non era uno di quelli di Barbara.
L’uomo sul letto della stanza 327 era nudo, immobile sotto l’unica luce accesa, una delle due applique sulla parete. Sul comodino c’erano una bottiglia di prosecco semivuota, con due bicchieri di plastica trasparente, e una busta di cellofan contenente residui di polvere bianca. Ne restavano tracce anche sul vetro del ripiano, da cui l’uomo doveva avere aspirato una dose generosa.
«Puoi andare», disse Medina ad Amanda.
Lei rimase immobile. Il reggiseno si gonfiava al ritmo del respiro. Anche il minitanga era piuttosto rigonfio. Amanda si chiamava in realtà Osvaldo Ungureanu e veniva da Sighisoara, in Transilvania.
«Rivestiti», insistette lui. «E chiama Ray, così ti viene a prendere.»
Lei annuì. Questa volta recepì il messaggio e andò verso una sedia su cui era deposto un minivestito nero.
Medina si avvicinò all’uomo sul letto. Si sarebbe acceso volentieri una sigaretta, ma non era il caso. Erano più o meno diciassette anni che operava con successo come assassino su commissione – la più criminosa delle sue numerose attività illegali – e fino a quel momento nessuna autorità aveva mai avvertito la sua presenza, nessuno lo aveva mai sospettato o collegato a niente di criminale. Del suo operato era al corrente solo un certo colonnello De Lorenzo del SISMI – o AISE, come si chiamava adesso – con il quale si era trovato a collaborare qualche tempo prima. Ma lui non avrebbe creato problemi.
La respirazione dell’uomo sul letto era lentissima. Aveva gli occhi chiusi e dalla bocca spalancata usciva un filo di saliva biancastra. Doveva essere già in coma. Lo si sarebbe potuto ancora salvare, se l’uomo fosse stato portato in ospedale e sottoposto a una serie di iniezioni di naloxone per neutralizzare l’overdose di eroina. Tuttavia Roberto Beltramini non sarebbe stato trovato fino al mattino, quando la cameriera fosse venuta a rifare la stanza. E per quell’ora, nella remota ipotesi che fosse ancora vivo, i danni subiti dal cervello sarebbero stati irreversibili.
Questa è la fine dell’anteprima gratuita.
Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile