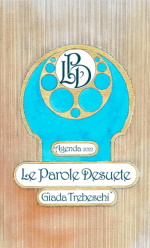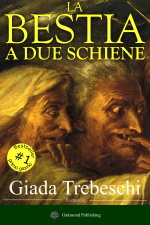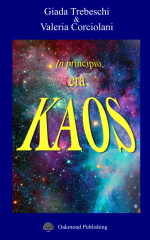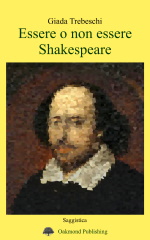Il vampiro di Venezia di Giada Trebeschi –
Vincitore Garfagnana in giallo 2017 –
Vincitore Palmastoria 2018 –
Un giallo storico coinvolgente e emozionante. L’autrice porta il lettore in giro per la Venezia di fine ‘500 e gli fa fare uno straordinario viaggio nel tempo e nello spazio. Non manca la vena thriller che non lascia tregua ed è difficile non leggere il romanzo d’un fiato. La ricostruzione storica è inappuntabile e la struttura giallistica calcolata al millimetro tanto che, cosa molto strana per un lettore di gialli come me, non sono riuscita a capire chi fosse davvero l’assassino fino al finale. Un libro davvero imperdibile. ![]()
![]()
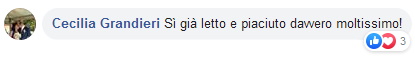
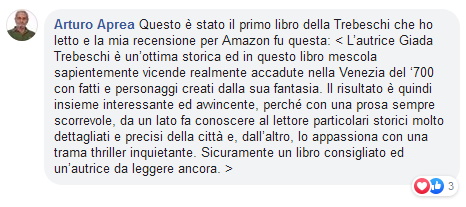
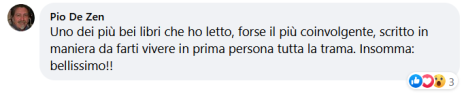
- Titolo: Il vampiro di Venezia
- Autore: Giada Trebeschi
- Lingua: Italiano
- Formati: kindle, copertina flessibile (256 pagine)
- Editore: Oakmond Publishing (2017)
- Generi: Romanzo, Thriller, Giallo, Romanzo storico, Saggisitica, Noir, Narrativa
Venezia, Natale 1576 – In un anno la morte nera ha falcidiato un terzo della popolazione della città e, come se non bastasse, la vigilia di Natale non solo avviene il primo di una serie di efferati omicidi ma sull’isola del Lazzaretto Nuovo scoprono una masticatrice di sudari, una sorta di vampiro, un mostro che torna dai morti cibandosi di sangue umano.
Nane Zenon, un alchimista in odore di negromanzia, rende il vampiro inoffensivo eppure il terrore non lascia tregua. Sono in molti a credere che gli omicidi abbiano a che fare con i masticatori e così, per volere del Doge in persona, Nane si troverà ad affiancare le indagini del Signore di notte al Criminàl Orso Pisani.
Orso è però un magistrato pragmatico che non crede ai succhia sangue né alle superstizioni e risolverà il caso minando le certezze di Nane e mettendolo di fronte a una realtà ben più terrificante di qualsiasi mostro immaginario.
Sullo sfondo di questa storia oscura e angosciosa la città dei mercanti, degli ebrei e degli arabi che non disdegnano di fare affari insieme; la Serenissima delle spie e delle cortigiane, dei segreti e degli intrighi, la magica e struggente Venezia dei ricami di pietra e degli amori impossibili.
Il romanzo s’ispira al ritrovamento del cosiddetto vampiro di Venezia cioè lo scheletro di una donna con un mattone in bocca, risalente agli anni della grande peste di fine ‘500 e rinvenuto sull’isola del Lazzaretto Nuovo durante gli scavi archeologici del 2006-2008.
Kindle e-book
Libro
Comincia a leggere qui gratuitamente l’incipit de
Il vampiro di Venezia:
Quando infine gli tagliarono la giugulare, non ci mise molto a morire. Fece appena in tempo a sentire il fiotto caldo del proprio sangue scivolargli lungo il collo prima del sopraggiungere di quello stato d’incoscienza simile al sonno, alla pace, alla morte tanto agognata. Durante il lungo supplizio al quale era stato sottoposto, seppe di essere dannato. Una vita intera a predicare la parola di Dio e ora la perdizione. Se non fosse stato per quegli occhi, neri come l’oscurità del peccato, che lo fissavano così da vicino, non avrebbe neppure saputo perché. Il terrore della punizione eterna gli si era insinuato nella mente come il brulichio di migliaia di vermi. Li aveva sentiti muoversi, masticargli le membra, avvertendo l’odore della propria carne in putrefazione e dei liquami che non era riuscito a trattenere che gli si seccavano addosso.
Era stato appeso per i piedi. Un oggetto freddo gli aveva sfiorato le parti intime. Certamente un coltello, ma in quegli ultimi momenti di delirio si era lasciato andare al ricordo di esperte dita sottili, forse giovani labbra o forse la lingua, sì, la lingua appuntita di una cortigiana. Aveva avuto un’erezione ma non era stato il culmine del piacere a provare per quella che sapeva sarebbe stata la sua ultima volta. Il dolore aveva raggiunto un picco insopportabile, e solo il terrore che gli si era incuneato fra il cervello e l’anima non gli aveva permesso di svenire. Pensò che lo avrebbero mangiato vivo.
Furono i due ragazzini che andavano a prepararsi per servire messa a trovarlo. Erano entrati in chiesa dalla porta principale dato che, stranamente, avevano trovato chiusa quella della sagrestia. Il più grande dei due aveva avuto conati di vomito, l’altro non era più riuscito a parlare per mesi. Lo spettacolo che avevano visto era raccapricciante. Non sarebbero mai più entrati nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, neppure da adulti.
Sul corpo nudo di Don Alvise la luce delle candele creava ombre che lo facevano sembrare un essere demoniaco. O meglio, un dannato cui erano state inflitte pene infernali e che ora si presentava al mondo con gli occhi girati al contrario, il volto bloccato in una smorfia di dolore e paura insieme, la carne in molti punti a brandelli e la lingua strappata e gettata come una bestemmia sull’altare maggiore. Sembrava esser stato dilaniato da una bestia feroce ma non vi erano quasi tracce di sangue.
«Tiratelo giù. E mandate fuori tutti» ordinò Orso Maria Pisani, il signore di notte al Criminàl, ovvero il magistrato cui erano stati affidati i compiti di controllo e gendarmeria in quel sestiere, quello di Dorsoduro.
Si sarebbe occupato lui di quel caso.
Era la vigilia di Natale del 1576 e, seppur con la paura della peste, la chiesa si andava riempiendo di curiosi richiamati dalle grida disperate dei ragazzi e dal trambusto che ne era seguito.
Davanti al morto, ancora penzolante dall’arco centrale dell’iconostasi bizantina, proprio a specchio rovesciato sotto il Cristo crocifisso, in molti si erano segnati. Bisbigliavano, ipnotizzati dal macabro spettacolo, dicendosi che quella poteva essere solo opera del diavolo. Così come lo era la terribile pestilenza che affliggeva la città e che sembrava non voler lasciar scampo a nessuno.
Gli untori erano di sicuro stati mandati dal signore delle tenebre, e doveva esserlo anche chi aveva osato compiere un’azione come quella, in una chiesa e, per colmo di blasfemia, la vigilia di Natale. Era un segno, un messaggio ultraterreno di chi voleva capovolgere l’ordine delle cose, così come aveva capovolto e martoriato il povero Don Alvise.
Tutte quelle chiacchiere, confuse tra scoppi di pianto isterico e preghiere più urlate che sussurrate, stavano dando sui nervi a Orso Maria Pisani. Patrizio veneziano dalla mente scientifica e razionale, che guardava con disprezzo tutto ciò che derivava dalla superstizione e dall’ignoranza, era certo che ogni spiegazione avesse le proprie radici in questo mondo e non in quell’altro, della cui esistenza, a ben vedere, non era nemmeno tanto sicuro. Ma erano convincimenti, questi, che riteneva prudente tenere per sé. Dovevano restare riflessioni private, così da preservare la libertà di pensare ciò che voleva. Venezia era una città di mercanti e traffichini che accettava di fare affari con gli infedeli, che ospitava ebrei, seppur nel ghetto, che riusciva, il più delle volte, a tener lontana l’Inquisizione e la lunga mano del Papa, ma non era il caso di provare fino a che punto fosse disposta ad accettare provocazioni su questioni di fede.
L’ultimo bagliore del crepuscolo si era già spento da un pezzo quando, finalmente, il corpo di Don Alvise venne adagiato su un lenzuolo ai piedi dell’altare.
«Portate altre candele» ordinò Pisani.
«Sembra essere stato aggredito a morsi. Non ho mai visto una cosa del genere. La ferocia di chi si è accanito sul suo corpo farebbe impallidire un branco di lupi» commentò sbigottito il cavadenti che era arrivato in chiesa per la messa ed era stato poi trattenuto per esaminare il corpo di Don Alvise.
«Lupi che oltre a sbranarlo vivo devono anche aver leccato via tutto il sangue» commentò Pisani quasi parlando a se stesso. «Una tale efferatezza e nemmeno una goccia di sangue sul pavimento.»
Era l’unico dettaglio che lo lasciasse davvero sgomento. Un dettaglio che fece persino vacillare la sua granitica razionalità: che ci fosse veramente lo zampino del demonio? Scacciò quel pensiero come si allontana una mosca fastidiosa, e cercò di raccogliere le idee.
Sì, voglio acquistarlo – Formato Kindle – Copertina flessibile
Il modo in cui il povero prete era stato issato a penzolare dall’iconostasi era piuttosto interessante. Per ridurre lo sforzo di tirare la corda era stato utilizzato un sistema di cime e bozzelli del tutto simili a quelli dei paranchi delle navi, lasciando supporre che l’assassino, che a maggior ragione doveva essere un uomo e non un essere dai poteri soprannaturali, avrebbe potuto lavorare all’Arsenale o essere un marinaio. Inoltre, il nodo fatto alla fune legata attorno a una colonna per sorreggere il corpo sembrava proprio una gassa d’amante. La cosa poteva certo orientare le indagini verso l’ambiente marinaresco ma, in fondo, a Venezia ogni uomo sopra e forse anche sotto i quattordici anni avrebbe potuto far quel nodo o conoscere quel sistema. No, quella pista non lo avrebbe condotto da nessuna parte.Il corpo di Don Alvise fu portato sul tavolo della sagrestia. Bisognava ispezionarlo minuziosamente prima di concedere il permesso alla tumulazione. E, giacché il prete non era morto di peste, si poteva attendere qualche ora in più prima seppellirlo.
Così fu mandato a chiamare, scortato fino al luogo del delitto, uno dei più noti cerusici ebrei della città. Pisani sperava che avrebbe potuto dare una spiegazione ai segni di morsi sulle povere membra del prete.
«A parte la lingua recisa di netto, il resto della carne sembra essere stato strappato a morsi. Di queste ferite ne ho contate sei. Sei, come il salmo che dice: Signore non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore» fu l’asciutto commento del cerusico.
«Quando è morto?»
«Da qualche ora, direi.»
«E il sangue, dov’è finito?» chiese nervoso Pisani, che si aspettava molto di più.
«Non lo so. Il sangue sembra essere stato succhiato via e anche attorno alle ferite non ve n’è rimasto molto. Se non l’avessi visto con i miei occhi, non ci avrei creduto. Sembra l’opera di un essere soprannaturale.»
«Anche voi con questa storia!» sbottò il magistrato. «Uscite. Tutti.»
Il signore di notte rimase solo in sagrestia con il cadavere di don Alvise.
Avrebbe voluto passarla diversamente, quella notte.
Quasi tutte le cortigiane oneste erano scappate dalla città per la paura del contagio, e quelle poche che erano rimaste erano richiestissime. Una di loro lo avrebbe aspettato al ritorno dalla messa. Ma avrebbe aspettato invano. Era così irritato da tutta quella storia che avrebbe potuto prendere a schiaffi la povera vittima. Sapeva che quel caso non solo gli aveva rovinato la nottata ma lo avrebbe tenuto occupato a lungo, per non parlare poi delle pressioni che sarebbero venute dal doge.
Gli indizi erano irrisori e le suggestioni soprannaturali preponderanti anche per lui: doveva ammetterlo.
Avrebbe dovuto però continuare a negare ogni intervento demoniaco o una nuova paura si sarebbe aggiunta al terrore della peste e dei suoi untori con chissà quali disastrose conseguenze.
In realtà, sapeva che la notizia si sarebbe sparsa velocemente e che, già la mattina seguente, sarebbe stata sulla bocca di tutti. L’unica cosa che poteva fare era quella di non alimentare tale convinzione oltre, naturalmente, trovare l’assassino.
Nel 1575, quando cioè era iniziata quella terribile epidemia che, con ogni probabilità, aveva viaggiato su qualche nave proveniente da Levante per poi irrompere nella vita dei veneziani come un’Idra velenosa e mortale, Orso era da poco rientrato in città. Qualche tempo prima si era trasferito a Padova per ultimare gli studi di Diritto, ed era tornato a Venezia in occasione del matrimonio della sorella.
A casa però non era stata una felice sposa novella ad accoglierlo ma la morte nera. Sua madre, insieme al bambino che portava in grembo, se l’era già portata via un parto una decina di anni prima, e adesso la peste si era presa suo padre. Lo avevano seppellito in fretta e furia, sperando che nessun altro in casa fosse stato contagiato, ma dal giorno successivo al funerale, Pisani aveva cominciato a sentirsi male. Sua sorella era riuscito a salvarla mandandola nelle tenute marchigiane del marito. Lui, invece, era rimasto a Venezia, nella vecchia casa di famiglia, in preda alla febbre, mentre degli enormi bubboni scuri avevano già invaso le ascelle e l’inguine.
Sapeva bene cosa significavano, ma anche come provare a guarire. Se, infatti, a Padova si applicava a studi che più aggradavano suo padre, il suo spirito scientifico e la sua curiosità lo avevano spinto a seguire, quasi di nascosto, diverse lezioni di medicina tenute da Girolamo Fabrici d’Acquapendente e a studiare, fra gli altri, il trattato De Contagione di Girolamo Fracastoro.
Per tutto il resto della vita se ne sarebbe rallegrato.
A letto, sfinito dai sudori e dai tremori della febbre, osservava quelle pustole nauseabonde. Non aspettò il medico e s’incise da solo le tumescenze infette. Le strizzò come fossero pustole dell’acne fin quasi a svenire. Si fece portare dell’acqua bollente e tutta la costosa acquavite friulana che suo padre era solito bere per vincere la pesantezza di stomaco. Ne bevve un lungo sorso e poi la mischiò all’acqua, cominciando a lavarsi accuratamente, tamponando le ferite che si era procurato e asciugandosi con panni di lino che poi gettò nel fuoco. Esausto, crollò sul letto dove rimase per i tre giorni successivi. Ogni mattina si faceva cambiare le lenzuola dando ordine di bruciarle. Beveva moltissima acqua, nella quale faceva aggiungere del succo di limone alla maniera dei marinai, rimanendo digiuno. Il quarto giorno era riuscito a sedersi sul letto senza alcun aiuto e a mandar giù del pane. Il quinto si alzò e fece il giro della stanza.
Forse le cure e gli accorgimenti che aveva adottato erano stati risolutivi, forse il suo fisico sano e vigoroso aveva combattuto la malattia con le proprie forze, forse entrambe le cose, non poté mai saperlo con sicurezza, ma una cosa era certa: sarebbe sopravvissuto alla peste.
Dopo essersi rimesso in salute, Orso non era tornato a Padova per concludere gli studi, ma era rimasto a Venezia, iniziando a occuparsi degli affari ereditati dal padre. All’inizio dell’anno successivo, il 1576, era stato nominato signore di notte al Criminàl e aveva sotto di lui una ventina di birri, scelti fra la gente del Sestiere, di cui disponeva per mantenere l’ordine in quella parte della città. Era ormai il solo patrizio che, nel Sestiere di Dorsoduro, non fosse scappato in campagna o che non fosse stato ucciso dalla peste e che avesse le capacità per svolgere quel compito. Inoltre, il doge, Alvise I Mocenigo, era stato buon amico di suo padre e conosceva abbastanza quel giovane per sapere che avrebbe adempiuto in maniera impeccabile il proprio dovere.
Davanti al cadavere di Don Alvise, Orso Maria Pisani si disse che avrebbe fatto meglio, quando ancora avrebbe potuto, a tornarsene a Padova.
Con un gesto di stizza coprì il corpo martoriato con un lenzuolo. Poi uscì dalla sagrestia chinando il capo per passare attraverso la porta che conduceva all’abitazione del prete, troppo bassa per lasciarlo passare ritto data la sua considerevole altezza di quasi sei piedi.
Decise di dare un’occhiata in canonica.
Entrando nella stanza la prima cosa che colpiva era il grande armadio di noce decorato con putti e grottesche, la sedia dantesca a forbice sulla quale era in bella vista un cuscino damascato verde e oro, e il tavolo al centro, anch’esso di noce, con pesanti gambe a zampa di leone. Più in fondo, verso il focolare, vi era una madia lineare ma di ottima fattura su cui poggiavano alcuni piatti d’argento.
Don Alvise doveva disporre di molto denaro per permettersi di vivere in quel lusso decisamente fuori luogo per un prete nella sua posizione. Non gli risultava che venisse da una famiglia ricca né che la parrocchia disponesse d’ingenti somme, ma aveva sentito dire che il prete aveva amicizie importanti. Non aveva mai dato molto peso ai pettegolezzi eppure, da quando era diventato signore di notte, si era reso conto di quanto potessero essere utili quelle chiacchiere spesso malevole e inopportune che spie e scagnozzi ascoltavano dai servi o al mercato, o che coglievano sulle labbra d’integerrimi patrizi o lungo i corridoi che portavano a udienza dal doge, e che gli venivano puntualmente riferite.
A proposito del morto aveva sentito dire che una cerchia sempre crescente di nobili veneziani se ne serviva per confessarsi, entrando con lui in una singolare familiarità, destando sospetti e ipotesi piccanti sulle ragioni che spingevano quei superbi patrizi ad accordare poi favori e a offrire costosi doni a quel pretuncolo di campagna.
Erano quei servigi che ora stuzzicavano la curiosità di Pisani. Che cosa avrebbe potuto offrire loro un sacerdote modesto come quello? Non aveva avuto modo di conoscerlo bene; Don Alvise era arrivato poco prima del suo trasferimento padovano ma suo padre non ne aveva mai avuto una grande considerazione.
E lui si fidava del giudizio di suo padre.
Si apprestava già a uscire quando lo sguardo gli cadde su uno dei grossi registri parrocchiali che giacevano sul tavolino accanto alla porta d’ingresso. Lo aveva sfogliato velocemente più per curiosità che per cercarvi qualcosa e si era accorto che, attentamente riposto fra le sue pagine, vi era un disegno a sanguigna di una donna nuda sdraiata di spalle con un velo che le cingeva la vita e con il volto girato di tre quarti verso l’osservatore. L’impressione fu quella di avere per le mani un disegno preparatorio o uno studio sul corpo, ma il volto della donna gli ricordava qualcuno e la mano dell’artista gli sembrò così buona che decise di requisirlo e di fare qualche domanda in giro.
Quando uscì dalla canonica era buio. Uno dei suoi uomini gli si fece incontro per domandargli se poteva consegnare il corpo di Don Alvise perché venisse preparato per il funerale, previsto per il pomeriggio successivo. Pisani pensò che ormai il cadavere non gli sarebbe stato più di alcuna utilità e concesse il permesso.
Dirigendosi verso la gondola di servizio dove lo aspettavano due birri, Pisani si strinse nel pesante mantello di lana. L’aria fredda e pungente della laguna gli faceva lacrimare gli occhi, così cercò di ripararsi dal vento accomodandosi sotto il fèlze dell’imbarcazione e ordinò di portarlo dal doge. Avrebbe dovuto informarlo dell’accaduto.
Orso cercava di riflettere. I suoi pensieri si muovevano al ritmo delle onde e, accompagnati dallo scintillio della luce della luna riflessa sull’acqua, sembrava avessero lo stesso uniforme andamento. Poi, d’un tratto, il guizzo di un pesce interruppe quel rassicurante dondolio, e l’uomo comprese che, per risolvere quel caso, avrebbe dovuto pensare fuori dagli schemi. La cosa più ovvia era cercare l’assassino del prete nell’ambiente marinaresco, stando al modo in cui era stato issato all’iconostasi, la più popolare quella di attribuire il fatto al demonio. Lui non si sarebbe lasciato trarre in inganno né dall’una né dall’altra.
L’istinto gli suggeriva di indagare in alcuni ambienti della nobiltà veneziana che, a quanto pareva, era in così buoni rapporti con il fu Don Alvise.
Quali torbide relazioni li univano? Alcuni, come d’altra parte la sua stessa famiglia, facevano parte del patriziato delle case nuove, acquistate per una cifra vicina ai centomila ducati d’oro da una nobiltà più recente e desiderosa di simboli che ne attestassero il lignaggio; ma aveva sentito dire che, persino alcuni patrizi appartenenti a due fra le ventiquattro case vecchie, quelle cioè di più antica nobiltà, avevano avuto contatti con Don Alvise. Gli sembrava strano che appartenenti a famiglie fra le più in vista della città si fossero abbassati fino al punto di andare a confessarsi da un prete di poco conto. Al doge non sarebbe piaciuta questa storia. Per niente.
La luna illuminava Palazzo Ducale accarezzandone i merli e i decori con la timidezza di una casta innamorata, s’intrufolava fra le colonne del porticato come a origliare i segreti più intimi di quel meraviglioso edificio. In quello splendido ricamo di pietra di segreti ve ne erano rimasti impigliati parecchi. Pisani sorrise a quell’idea e, riconosciuto dalle guardie, fu lasciato passare.
Il doge non era in casa.
Era la vigilia di Natale e aveva deciso di trascorrere la serata nel palazzo di famiglia. Palazzo Mocenigo, si trovava nel Sestiere di Santa Croce, poco lontano dalla chiesa di San Stae. Pisani calcolò che avrebbe dovuto percorrere più della metà del Canal Grande per arrivarci e ci sarebbe voluto un bel po’ di tempo. Quell’imprevisto, ragionava, in fondo gli tornava utile: avrebbe potuto riflettere con più calma sull’accaduto.
Non era ancora tornato alla gondola di servizio che si fermò sul molo a osservare un’imbarcazione scura, il cosiddetto topo, carico di persone fino all’inverosimile. La barca scivolava sull’acqua silenziosamente e, sebbene fossero in molti a bordo, nessuno proferiva parola.
Erano quelle le povere anime dirette al Lazzaretto Novo, uomini e donne che avrebbero trascorso ventidue giorni d’isolamento in un terribile limbo, in attesa di sapere se erano stati contagiati dalla morte nera. Esposti al rischio del contagio, qualora si fossero rivelati appestati, sarebbero stati trasferiti al Lazzaretto Vecchio in attesa della morte o di una quanto mai improbabile guarigione.
«Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: “Guai a voi anime prave”! Non isperate mai veder lo cielo; i’ vegno per menarvi all’altra riva ne le tenebre eterne, in caldo e ’n gelo» mormorò.
I versi del sommo poeta parvero a Pisani gli unici a poter fare da commento a quel terribile spettacolo. Per coloro che erano stati contagiati, il viaggio successivo sarebbe stato non più sulle acque della laguna, ma attraverso l’Acheronte, con un vecchio dagli occhi di bragia come nocchiero.
Il pianto di un bambino proveniente dalla barca fantasma che gli passava davanti lo distolse da quei pensieri.
«E tu che se’ costì, anima viva», sussurrò risalendo sulla gondola, «pàrtiti da cotesti che son morti.»
«Lupi che oltre a sbranarlo vivo devono anche aver leccato via tutto il sangue» commentò Pisani quasi parlando a se stesso. «Una tale efferatezza e nemmeno una goccia di sangue sul pavimento.»
Era l’unico dettaglio che lo lasciasse davvero sgomento. Un dettaglio che fece persino vacillare la sua granitica razionalità: che ci fosse veramente lo zampino del demonio? Scacciò quel pensiero come si allontana una mosca fastidiosa, e cercò di raccogliere le idee.
Sì, voglio acquistarlo – Formato Kindle – Copertina flessibile
II
Quando la barca fantasma arrivò vicino al Lazzaretto Novo i suoi passeggeri furono trasbordati su un altro barcone. In un triste e composto silenzio, quelle creature in pena si ammassavano su un natante ancorato nei pressi dell’isola. Nemmeno i bambini che erano a bordo piangevano più. Una donna con al seno un neonato aveva il volto inumidito da gocce salate; un’angoscia che quasi non le permetteva di respirare si era impossessata di lei e il suo pianto disperato sgorgava dagli occhi senza far rumore. L’arsenalotto che l’aiutò nel trasbordo, guardandola in viso rimase muto davanti a quella bellezza addolorata; teneva la mano a una madonna delle lacrime che presagiva l’ineluttabile.
Sull’isola non avrebbero potuto trovare posto tutte le persone che ogni giorno arrivavano a migliaia, e così il Senato della Serenissima aveva autorizzato l’ancoraggio, nei pressi del Lazzaretto, di barconi preposti alla contumacia di persone sospette di contagio. Erano state dunque approntate più di duemila barche di ogni tipo, stracariche di gente che, viste da terra davano l’impressione di un’immensa armata infernale all’assedio dell’isola.
Soltanto un uomo rimase sulla prima barca insieme ai traghettatori. Un uomo sulla trentina, con folti capelli scuri, avvolto in un lungo mantello nero chiuso da una fibbia d’argento a forma di croce con una rosa al centro, seminascosto da un ampio cappuccio.
Si chiamava Nane Zenon e fu fatto scendere a terra.
Arrivando sull’isolotto la prima cosa che lo colpì fu l’odore dell’aria. Non si trattava di quell’odore salato e dolciastro tipico della laguna, e nemmeno dell’olezzo di uomini e merci caratteristico del porto, no, nell’aria vi era profumo di buono, un profumo che illudeva il dolore e che sapeva di ginepro e rosmarino.
Il Lazzaretto Novo era luogo di contumacia non solo per le persone a rischio di contagio ma anche per navi e merci provenienti dai vari porti del Mediterraneo che giungessero con issata la bandiera gialla o sospettate di essere portatrici del morbo dal medico di Punta della Dogana. Dal mare le costruzioni dell’isola avevano la sembianza di un castello fortificato a causa di quel centinaio di camini alla veneziana, posti a ridosso del muro di cinta, di cui erano dotate le camere per gli ospiti in quarantena.
Una volta sull’isola, a parte i caselli da polvere, era un’imponente costruzione a calamitare l’attenzione: il Tezon Grando. Si trattava del principale edificio dell’isola lungo più di cento metri e destinato alla quarantena delle merci per l’espurgo delle quali, negli spazi interni, erano state costruite delle teze, una sorta di grandi tettoie sotto le quali venivano bruciati interi prati di erbe aromatiche.
Marco Fogal, il priore laico nominato dal Magistrato alla Sanità, e responsabile del buon funzionamento del Lazzaretto, aspettava Nane Zenon al molo. Gli strinse la mano e lo invitò a seguirlo. La luce tremolante della fiaccola lasciava intravedere scorci del paesaggio circostante e, quando passarono davanti al Tezon Grando, il breve chiarore della fiamma illuminò alcune scritte sul muro. Nane osservò che esse palesavano un’intensa attività di mercanti e bastazi i quali, pur con la paura della peste, continuavano a commerciare e trasportare le merci provenenti da Costantinopoli, Nauplia, Cipro, Alessandria, così come da molti altri luoghi lontani di cui non riusciva a pronunciare nemmeno i nomi.
Le costruzioni per le persone in quarantena non erano molto lontane. Vi passarono davanti ma non entrarono.
Loro erano diretti al camposanto.
A dir il vero, non avrebbe dovuto esserci nessun cimitero al Lazzaretto Novo. Ma quello del Lazzaretto Vecchio non aveva più posto: la popolazione di Venezia era stata falciata ormai quasi di un terzo e i cadaveri andavano seppelliti in fretta per evitare ulteriori contagi. Le sepolture, ormai quotidiane, non andavano molto per il sottile, così i morti venivano avvolti in semplici sudari, gettati in una fossa comune e poi ricoperti di terra.
Si trattava di una procedura piuttosto normale, che i necrofori svolgevano abitualmente, ma nel pomeriggio di quell’antivigilia di Natale del 1576, era avvenuto un fatto terribile. Scavando per seppellire nuovi cadaveri, alcuni uomini si erano imbattuti in qualcosa di spaventoso.
Avevano immediatamente avvisato il priore, Marco Fogal, il quale aveva predisposto tre guardie armate per sorvegliare la tomba fino a nuovo ordine. Nel frattempo era stato mandato a chiamare Nane Zenon, che però non sarebbe rientrato in città che il giorno successivo.
I tre soldati di guardia quella notte non avevano osato avvicinarsi al sepolcro.
Era parso loro di sentire uno strano rumore proveniente dalla fossa, rumore che assomigliava spaventosamente al borbottio di un animale che rumina. Erano rimasti tutto il tempo a spade sguainate incapaci di muoversi con l’animo in preda ad un’agitazione fuori dal comune.
Il più vecchio fra loro, sebbene facesse decisamente freddo, aveva la fronte imperlata di sudore. Gocce gelate gli colavano sul viso e lungo la schiena, facendolo rabbrividire e causandogli un tremore che non era più in grado di controllare. Dopo appena mezz’ora, una forte sensazione di soffocamento cominciò a causargli un profondo dolore al petto. A un certo punto, cadde carponi cercando di soddisfare quella fame d’aria che, lo sentiva, gli avrebbe presto fatto perdere i sensi.
Uno dei suoi compagni gli si era avvicinato per aiutarlo a mettersi seduto. Il tocco dell’amico e il suono delle poche parole che aveva pronunciato mentre lo assisteva ebbero un effetto tranquillizzante. Tornò a respirare normalmente; il dolore al petto era passato. L’unica cosa da cui non riusciva a liberarsi era una disgustosa sensazione di nausea. Aveva vomitato due volte prima di riuscire, finalmente, a parlare.
«Allontaniamoci da questa tomba. Siamo troppo vicini. Possiamo sorvegliarla anche a distanza. Lasceremo qui due fiaccole per illuminarla meglio, ma spostiamoci da questo posto dannato» …
Questa è la fine dell’anteprima gratuita.